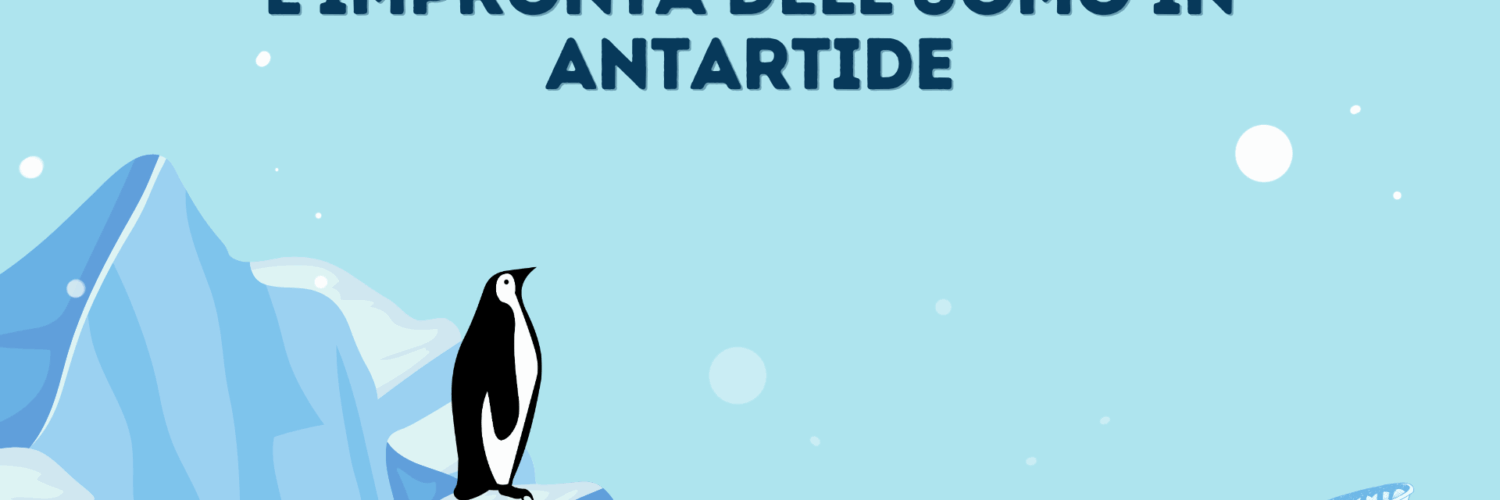Siamo ricercatrici polari, ecologhe e giuriste che studiano l’Antartide da anni, e l’impatto di un’impronta umana su un ecosistema così incontaminato. L’Antartide è un continente di estremi: il più freddo, ventoso e secco, con il 70% dell’acqua dolce globale e un Oceano Antartico cruciale per l’assorbimento di calore e carbonio. È una riserva naturale dedicata alla pace e alla scienza, come stabilito dal Protocollo di Madrid. Solo organismi resistenti, come cinque specie di pinguini che costituiscono il 90% della biomassa terrestre, vi trovano casa. Tuttavia, l’uomo è arrivato. Le aree deglaciate sono ora occupate da insediamenti scientifici di 18 paesi, con oltre 10.000 scienziati e più di 124.000 turisti nell’estate 2023-2024. Nonostante rigorose norme che vietano test nucleari, attività estrattive e impongono valutazioni ambientali, con l’uomo sono arrivati i rifiuti. Silos arrugginiti, acque reflue, reti da pesca e, soprattutto, la plastica (pannelli isolanti, sacchetti, imballaggi) e le microplastiche inquinano l’ambiente. In alcune regioni, questi rifiuti sono un incontro quotidiano per la fauna selvatica, che purtroppo vi si abitua. Piccoli invertebrati come i collemboli ingeriscono microplastiche, e nel 2016, 10 kg di rifiuti sono stati raccolti su soli 500 metri di costa.
Oggi, gli scienziati affrontano questa sfida, assumendosi la responsabilità delle tracce lasciate. L’Antartide deve essere protetto e condiviso come bene comune. È nostra responsabilità preservarlo. C’è ancora tempo per agire, ma dobbiamo farlo ora.
Ilaria Corsi, Silvia Simonetti, Emma Ferrari, Silvia Olmastroni, Patrizia Vigni, Elisa Bergami
Scienze Fisiche, della Terra e dell’ambiente
SDGS: 14 – La vita sott’acqua, 15 – La vita sulla terra